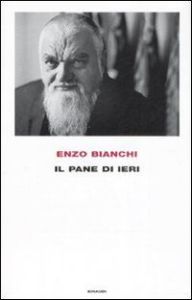L'angoscia di fronte alla domanda: "che tempo fa?" è certo più forte quando un semplice evento atmosferico può distruggere in pochi minuti un anno di lavoro. Allora non è poi così strano vedere il parroco del paese incedere nella tempesta, il piviale viola scosso dal vento, fendere l'aria con l'aspersorio dell'acquasanta e implorare con voce ferma Dio di fermare la grandine: "Per Deum verum, per Deum vivum". In un mondo sempre più abitato da suoni nuovi e pervasivi è facile perdere le voci antiche che scandivano lo scorrere del tempo: il canto del gallo all'alba, il rintocco delle campane che annunciava momenti lieti o tristi, il grido dell'acciugaio e il richiamo del venditore ambulante di carta da lettere. Suoni quotidiani, destinati a tutti. Il cibo, a ben guardare, oltre che un nutrimento necessario è anche qualcosa di cui si deve "aver cura". La tavola è luogo di incontro e di festa e la cucina è un mondo in cui si intrecciano natura e cultura. Preparare il ragù può diventare allora un momento di meditazione e la bagna càuda un vero e proprio rito in cui gli ingredienti che la compongono rappresentano uno scambio di terre, di genti, di culture. A dispetto di ogni localismo (anche culinario) tutti i cibi anche i più nostrani, sono carichi di debiti con l'esterno e con chi, in terre lontane, ha coltivato le materie prime, le ha fatte crescere e le ha raccolte. Storie ricche di personaggi singolari, di saggezza popolare, di amore per la terra, di riflessioni sulla vita, la morte e la ricchezza della diversità.
----------------------
La recensione di IBS
Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, in provincia di Biella, ha raccolto in questo testo una serie di storie del "tempo che fu", nate dalla saggezza accumulata in sessantacinque anni di vita al servizio della fede, dell'amicizia, del vivere insieme e dell'ospitalità. Le riflessioni partono da un'etica della propria terra, che per Bianchi è il piccolo paese di Castel Boglione (in piemontese Castervé), nel Monferrato, un borgo di settecento anime adagiato sulle rive dell'Erro e della Bormida dove l'autore andava a fare il bagno d'estate, circondato dalle colline disegnate dalla vite e dalle terre dissodate dall'aratro, allora ancora trainato dai buoi. Una vita dura, contadina, scandita dai ritmi del raccolto, dalla quale l'autore estrapola i quattro comandamenti appresi dal padre: fare il proprio dovere a costo di crepare; non esagerare, non ostentare; non prendersela, e attenuare il dolore; infine, "non mescolare le cose", come principio minimo di ordine contro l'impurità. Questi quattro "comandi monferrini" sono il magistero umano sul quale ruota il libro, una morale laica e popolare che viene rintracciata anche nelle biografie di noti piemontesi come Cesare Pavese, Norberto Bobbio e Vittorio Alfieri. Anche allora, negli anni '50 e '60, c'era l'ossessione per "il tempo che fa", ma era tanto diversa dalla curiosità un po' frivola dei nostri giorni; le calamità naturali portavano davvero fame e disperazione, e "ieri era Dio colui in cui si aveva fede e fiducia, mentre oggi sembra esssere la meteorologia".
Le storie raccontate da Bianchi sono piene di amore per la terra, sono meditazioni sulla gioia, sulla vecchiaia, e se tornano al passato è per parlarci della nostra condizione di oggi. I rintocchi delle campane, il canto del gallo, le voci dei venditori ambulanti vengono rievocati per criticare il rumore di oggi nel quale, assieme al silenzio, abbiamo smarrito la sapienza di una quotidianità rappacificata con la natura e con gli altri. Anche i riferimenti alla cultura del cibo e della tavola sono numerosi e la cucina in queste pagine diviene luogo privilegiato per ascoltare, per umanizzare le relazioni, per imparare, un'unica radice che accomuna sapere e sapore. Cucinare, far da mangiare per una persona amata – scrive Enzo Bianchi – è il modo più semplice e concreto per dirgli: "Ti amo, perciò voglio che tu viva e viva bene, nella gioia!" E così nel libro si parla molto anche delle virtù della vite e del vino, del rito tutto piemontese della bagna càuda, della comunione del pane come momento conviviale che precede la preghiera o la messa della domenica. Quello che qui viene evocato è un mondo intenso, arcaico, fatto di valori antichi ma ancora validi, proprio come "il pane di ieri è buono domani" (el pan ed sèira, l'è bon admàn), l'adagio del Monferrato che fa da premessa a questa stimolante lettura.
| LoC Classification |
BX4705.B48685 .A3 2008 |
| Dewey |
271.0092 |
| N. di pagine |
114 |
| Altezza x Larghezza |
230
mm |
|
|
| Prestato da |
Rita Travaglino |
| Fine Lettura |
07/02/2014 |
| Da leggere |
No |
| Consultazione |
No |
| Num. Volte letto |
1 |
|
Un libro davvero piacevole con pagine da rileggere e ricordare anche se un briciolo stereotipate. Chiaramente letto con spirito di parte essendo un torinese-langarolo.